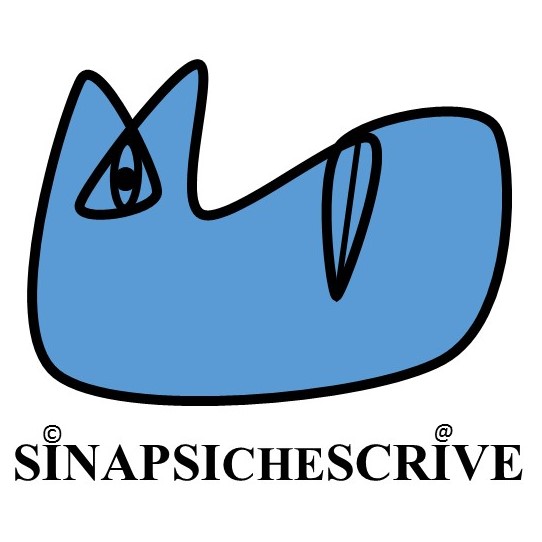Anche GRANDI autori hanno scritto
piccoli racconti.
Una storia al mese.

“Che altri si vantino delle pagine che hanno scritto. Io sono orgoglioso di quelle che ho letto”
(Jorge Luis Borges)
Dicembre 2024
Novembre 2024
Ottobre 2024
Settembre 2024
Agosto 2024
Luglio 2024
Giugno 2024
Maggio 2024
Aprile 2024
Marzo 2024
Febbraio 2024
Immagine di pch.vector</a> su Freepik
Febbraio 2024

Arrenditi!
di Franz Kafka
Era molto presto di mattina, le strade pulite e vuote, andavo alla stazione. Quando confrontai l’orologio della torre con il mio, vidi che era già molto più tardi di quanto credessi, dovevo accelerare molto il passo, il terrore/sconcerto per questa scoperta mi fece diventare insicuro sulla strada da fare, non ero ancora molto pratico di questa città, per fortuna c’era un vigile nelle vicinanze, corsi da lui e senza fiato gli chiesi la strada. Lui rise e disse: «Da me tu vuoi sapere la strada?». «Sì – dissi io – perché da solo non so trovarla.» «Arrenditi, arrenditi» disse lui e si girò con grande slancio, come fa la gente che vuole essere sola con la sua risata.

Franz Kafka (1883-1924) è stato uno scrittore boemo di lingua tedesca è ritenuto una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo e importante esponente del modernismo, del surrealismo e del realismo magico.
Marzo 2024

Lunedì o martedì
di Virginia Woolf
Pigro e indifferente, nello scuotere disinvolto lo spazio dalle sue ali, sicuro del suo andare, l’airone passa sopra la chiesa, sotto al cielo.
Bianco e distante, assorto in sé stesso, copre e scopre incessante il cielo, si sposta e rimane. Un lago? Cancella le sue rive! Una montagna? Oh, perfetto – il sole dorato sui suoi pendii. Dietro questa si eclissa. E poi felci, o piume bianche, per sempre, per sempre –
Desiderare la verità, attenderla, laboriosamente distillare poche parole, per sempre desiderare – (un grido si leva da sinistra, un altro da destra. Ruote stridono divergenti. Conglomerati di Omnibus in conflitto) – desiderare per sempre – (l’orologio assevera con dodici rintocchi che è mezzogiorno; la luce emana lame dorate; bambini sciamano) – per sempre desiderare la verità.
Rossa è la volta; monete pendono dagli alberi; il fumo si trascina su per i camini; latrati, urla, il grido “Ferro da vendere” – e la verità?
Irraggiati in un punto, piedi di uomo e di donna, incrostati di nero o d’oro – (Questo tempo nebbioso – Zucchero? No, grazie – Il Commonwealth del futuro) – il caminetto lancia dardi di luce e arrossa la stanza, ma non le figure scure e i loro occhi lucenti, mentre fuori un autocarro scarica, Miss Vattelapesca beve il tè al suo tavolo, e la vetrina preserva cappotti di pelliccia –
Ostentata, leggera come una foglia, accumulata negli angoli, soffiata tra le ruote, schizzata d’argento, a casa o non a casa, raccolta, sparpagliata, frantumata in singole scaglie, spazzata su, giù, strappata, affondata, composta – e la verità?
Ora accanto al fuoco ricordare sul bianco riquadro di marmo. Da profondità d’avorio parole in crescendo diffondono la loro nerezza, sbocciano e penetrano. Caduto il libro;
nella fiamma, nel fumo, nelle scintille fugaci – o viaggiando ora, il quadrato di marmo a pendere, minareti al di sotto e mari dell’India, mentre lo spazio corre azzurro e le stelle splendono – la verità? Contentezza della vicinanza?
Pigro e indifferente l’airone ritorna; il cielo vela le sue stelle; poi le scopre.

Adeline Virginia Woolf (1882–1941), è stata una scrittrice, saggista e attivista britannica. Considerata come una delle principali figure della letteratura del XX secolo, attivamente impegnata nella lotta per la parità di diritti tra i sessi.
Aprile 2024

Il vecchio nonno ed il nipotino
di Lev Tolstòj
Il nonno era molto vecchio. Le gambe non lo portavano più, i suoi occhi non vedevano, le sue orecchie non udivano, egli non aveva più denti e quando mangiava faceva la bava.
Il figlio e la nuora cessarono di fargli posto a tavola e lo mandarono a mangiare dietro la stufa.
Un giorno gli fu portato il cibo in una scodella. Tentando di muoverla, egli la lasciò cadere e la scodella si ruppe. La nuora cominciò a insultare il vecchio, rimproverandogli di guastare tutto nella casa, di rovinare le stoviglie e dichiarò che da allora in poi gli avrebbe dato da mangiare in una ciotola di legno.
Il vecchio sospirò, senza dire nulla.
Un giorno che il contadino e sua moglie erano rimasti in casa videro il loro bambino divertirsi, per terra, con dei pezzi di legno che cercava di mettere insieme. Il padre gli disse:
«Che stai facendo, Michele?».
Michele rispose: «Fabbrico una ciotola. Quando tu e la mamma sarete vecchi, mi servirà per darvi da mangiare».
Il contadino e sua moglie si guardarono e scoppiarono in lagrime. Ebbero vergogna del loro comportamento verso il vecchio: da quel giorno gli ridiedero un posto a tavola e lo circondarono di cure.

Lev Nikolàevič Tolstòj, in italiano anche noto come Leone Tolstoi (1828-1910) è stato uno scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo.
Immagine di Harryarts su Freepik</a>
Maggio 2024

Verde Azzurro
di Virginia Woolf
VERDE
Le acuminate dita di vetro pendono dall’alto. La luce scivola giù lungo il vetro e goccia una pozza di verde. Per tutto il giorno le dieci dita del lampadario sgocciolano il verde sul marmo. Le piume dei parrocchetti – le loro lamentose strida – le foglie aguzze delle palme – verdi anch’esse; verdi aghi che scintillano al sole. Ma il duro vetro continua a sgocciolare sul marmo; le pozze si librano sopra la sabbia del deserto; i cammelli vi si acquattano; le pozze si posano sul marmo; i giunchi le orlano; le alghe li intarsiano; qua e là un fiore bianco; la rana fa un balzo; di notte le stelle appaiono intatte. Viene la sera e l’ombra spazza via il verde sulla cappa del camino; la superficie increspata dell’oceano. Non arrivano navi; le onde senza scopo si agitano sotto il cielo vuoto. È notte; gli aghi sgocciolano chiazze d’azzurro. Il verde è svanito.
AZZURRO
Il mostro dal naso camuso affiora in superficie e spruzza dalle narici schiacciate due colonne d’acqua, di un bianco lucente al centro, che si sprizzano in una frangia di perline azzurre. Pennellate di azzurro rigano l’incerata nera del suo manto. Spruzzando acqua da bocca e narici, s’inabissa, carico d’acqua, e l’azzurro si richiude su di lui, inghiottendo i ciottoli lustri dei suoi occhi. Prostrato, gettato sulla spiaggia, vi si accascia, ottuso, perdendo aride scaglie azzurre. La loro tinta metallica macula il ferro arrugginito sulla spiaggia. Azzurre sono le costole della barca a remi naufragata. Un’onda rotola sotto le campane blu azzurre. Ma la cattedrale è differente, fredda, gravata di incenso, azzurro tenue dai veli delle madonne.

Adeline Virginia Woolf (1882–1941), è stata una scrittrice, saggista e attivista britannica. Considerata come una delle principali figure della letteratura del XX secolo, attivamente impegnata nella lotta per la parità di diritti tra i sessi.
Immagine di freepik</a>
Giugno 2024

La risposta
di Fredric William Brown
Con gesti lenti e solenni Dwar Ev procedette alla saldatura, in oro, degli ultimi due fili. Gli occhi di venti telecamere erano fissi su di lui e le onde subteriche portarono da un angolo all’altro dell’universo venti diverse immagini della cerimonia.
Si rialzò con un cenno del capo a Dwar Reyn, e s’accostò alla leva dell’interruttore generale: la leva che avrebbe collegato, in un colpo solo, tutti i giganteschi calcolatori elettronici di tutti i pianeti abitati dell’Universo – 96 miliardi di pianeti abitati – formando il super circuito da cui sarebbe uscito il supercalcolatore, un’unica macchina cibernetica racchiudente tutto il sapere di tutte le galassie.
Dwar Reyn rivolse un breve discorso agli innumerevoli miliardi di spettatori. Poi, dopo un attimo di silenzio disse: “Tutto è pronto Dwar Ez”. Dwar Ez abbassò la leva. Si udì un formidabile ronzio che concentrava tutta la potenza, l’energia di novantasei miliardi di pianeti. Grappoli di luci multicolori lampeggiarono sull’immenso quadro, poi, una dopo l’altra si attenuarono. Draw Ez fece un passo indietro e trasse un profondo respiro. “L’onore di porre la prima domanda spetta a te, Dwar Reyn”. “Grazie” rispose Dwar Reyn “Sarà una domanda cui nessuna macchina cibernetica ha potuto, da sola, rispondere”. Tornò a voltarsi verso la macchina. “C’è Dio?”. L’immensa voce rispose senza esitazione, senza il minimo crepitio di valvole o condensatori.
“Sì: adesso, Dio c’è.”
Il terrore sconvolse la faccia di Dwar Ev, che si slanciò verso il quadro di comando.
Un fulmine sceso dal cielo senza nubi lo incenerì, e fuse la leva inchiodandola per sempre al suo posto.

Fredric William Brown (1906 – 1972) è stato uno scrittore statunitense di fantascienza e di gialli.
Immagine di freepik</a>
Luglio 2024

Il gatto sotto la pioggia
di Ernest Miller Hemingway
C’erano solo due americani alloggiati in quell’albergo. Non conoscevano nessuna delle persone che incontravano per le scale quando andavano e venivano dalla loro stanza. La loro stanza era al primo piano e dava sul mare. Dava anche sul giardino pubblico e sul monumento ai caduti. Nel giardino pubblico c’erano grandi palme e panchine verdi. Col tempo bello c’era sempre un pittore col suo cavalletto.
Ai pittori piaceva come crescevano le palme, e i vivaci colori degli alberghi affacciati sul giardino pubblico e sul mare. Gli italiani venivano da lontano a vedere il monumento ai caduti, che era di bronzo e luccicava sotto la pioggia. Pioveva. La pioggia gocciolava dai palmizi. L’acqua stagnava nelle pozzanghere sulla ghiaia dei sentieri. Il mare si rompeva in una lunga riga sotto la pioggia e scivolava sul piano inclinato della spiaggia per tornare su a rompersi di nuovo in una lunga riga sotto la pioggia.
Le macchine erano sparite dalla piazza vicino al monumento. Oltre la piazza, sulla soglia del caffè, un cameriere stava guardando fuori verso la piazza deserta. La moglie americana stava guardando fuori dalla finestra. Fuori, proprio sotto la finestra, un gatto era accucciato sotto uno dei tavoli verdi gocciolanti. Il gatto cercava di raggomitolarsi su se stesso per non farsi bagnare dalle gocce. «Vado giù a prendere quel micino» disse la moglie americana.
«Ci vado io» propose dal letto suo marito. «No, vado io. Quel povero micino si è nascosto sotto un tavolo per non bagnarsi.» Il marito continuò a leggere, disteso ai piedi del letto con la testa appoggiata ai due cuscini. «Non bagnarti» disse. La moglie scese al pianterreno e il proprietario dell’albergo le fece un inchino mentre passava davanti all’ufficio. Il suo scrittoio era in fondo alla stanza. Era un uomo anziano e molto alto. «Piove» disse l’americana. Le era simpatico, quell’albergatore.
«Sì, sì, signora, brutto tempo. Il tempo è molto brutto.» Era ritto dietro il suo scrittoio in fondo alla stanza semibuia. L’americana lo trovava simpatico. Le piaceva la tremenda serietà con cui accoglieva i reclami. Le piaceva la sua dignità. Le piaceva il desiderio che mostrava di servirla. Le piaceva la considerazione che aveva per il proprio mestiere. Le piacevano la sua faccia, vecchia e pesante, e le sue mani. Sempre pensando che quell’uomo le piaceva, aprì la porta e guardò fuori. Si era messo a piovere più forte.
Un uomo con un mantello di gomma stava attraversando la piazza deserta nella direzione del caffè. Il gatto doveva essere sulla destra. L’americana pensò che forse poteva procedere sotto le grondaie. Mentre stava sulla soglia un ombrello si aprì dietro di lei. Era la cameriera addetta alla loro stanza. «Non deve bagnarsi» sorrise, parlando in italiano. Naturalmente, l’aveva mandata l’albergatore. Con la cameriera che le teneva l’ombrello sopra la testa, camminò sulla ghiaia del sentiero finché non fu sotto la finestra.
C’era il tavolo, di un verde ravvivato dalla pioggia, ma il gatto era sparito. L’americana fu presa da un inaspettato disappunto. La cameriera alzò lo sguardo a lei. «Ha perduto qualcosa, signora?» «C’era un gatto» disse l’americana. «Un gatto?» «Sì, un gatto.» «Un gatto?» rise la cameriera. «Un gatto sotto la pioggia?» «Sì» disse lei «sotto il tavolo.» Poi: «Oh, lo desideravo tanto. Volevo un micino». Quando parlò in inglese la fronte della cameriera si accigliò. «Venga, signora» disse. «Dobbiamo rientrare. Si bagnerà.» «Credo anch’io» disse l’americana.
Tornarono indietro sulla ghiaia del sentiero e varcarono la soglia. La cameriera restò fuori a chiudere l’ombrello. Mentre l’americana passava davanti all’ufficio, il padrone dallo scrittoio le fece un inchino. La ragazza si sentiva, dentro, qualcosa di molto piccolo e duro. Il padrone la faceva sentire molto piccola e davvero importante al tempo stesso. L’americana ebbe la sensazione passeggera di essere una persona straordinariamente importante. Salì le scale. Aprì la porta della stanza. George era sdraiato sul letto e leggeva.
«Hai trovato il gatto?» chiese, posando il libro. «È sparito.» «Chissà dov’è andato» disse lui, riposandosi gli occhi dalla lettura. Lei si sedette sul letto. «Lo desideravo tanto» disse. «Non so perché lo desideravo tanto. Volevo quel povero micino. Non è affatto divertente essere un povero micino fuori sotto la pioggia.» George si era rimesso a leggere. Lei andò a sedersi davanti allo specchio della toeletta e si guardò con lo specchio da viaggio. Studiò il suo profilo, prima da una parte e poi dall’altra. Poi si esaminò la nuca e il collo.
«Non credi che sarebbe una buona idea se mi lasciassi crescere i capelli?» chiese, guardando nuovamente il suo profilo. George alzò gli occhi e vide la sua nuca, con i capelli corti come quelli di un ragazzo. «A me piacciono così come sono.» «Sono stufa» disse lei. «Sono stufa di sembrare un ragazzo.» George, sul letto, cambiò posizione. Non aveva distolto lo sguardo da sua moglie da quando lei si era messa a parlare. «Sei maledettamente bella» disse. Depose specchio sulla toeletta e andò alla finestra e guardò fuori. Stava facendosi buio.
«Voglio pettinarmi con i capelli all’indietro, lisci e ben tirati, e farmi sulla nuca un bel nodo grosso e pesante» disse lei. «Voglio avere un gatto da tenere sulle ginocchia, e che faccia le fusa quando lo accarezzo.» «Sì?» disse George dal letto. «E voglio mangiare: a tavola con la mia argenteria e voglio delle candele. E voglio che sia primavera e voglio spazzolarmi i capelli davanti, allo specchio e voglio un gattino e voglio dei vestiti nuovi.» «Oh, smettila e cercati qualcosa da leggere» disse George. Aveva ripreso la lettura. Sua moglie guardava fuori dalla finestra.
Ormai era buio pesto e sulle palme continuava a piovere. «Comunque, voglio un gatto» disse lei «voglio un gatto. Voglio subito un gatto. Se non posso avere i capelli lunghi o se non posso divertirmi, posso almeno avere un gatto.» George non ascoltava. Stava leggendo il suo libro. Sua moglie guardò la piazza, fuori dalla finestra, dove si erano accese le luci. Qualcuno bussò alla porta. «Avanti» disse George. Alzò gli occhi dal libro. Sulla soglia c’era la cameriera. Teneva in braccio, stringendoselo al petto, un gattone color tartaruga, con le zampe posteriori penzoloni. «Mi scusi» disse «il padrone mi ha ordinato di portare questo alla signora.»

Ernest Miller Hemingway (1899-1961) è stato uno scrittore e giornalista statunitense. Fu autore di romanzi e racconti.
Immagine di freepik</a>
Agosto 2024

Chissà come si divertivano
di Isaac Asimov
Margie lo scrisse perfino nel suo diario, quella sera. Sulla pagina che portava la data
17 maggio 2157, scrisse: “Oggi Tommy ha trovato un vero libro!”
Era un libro antichissimo. Il nonno di Margie aveva detto una volta che, quand’era
bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c’era stata un’epoca in cui tutte le storie e
i racconti erano stampati su carta. Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti,
ed era buffissimo leggere parole che se ne stavano ferme invece di muoversi, com’era
previsto che facessero: su uno schermo, è logico. E poi, quando si tornava alla pagina
precedente, sopra c’erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima volta
– Mamma mia, che spreco – disse Tommy. – Quando uno è arrivato in fondo al libro,
che cosa fa? Lo butta via, immagino. Il nostro schermo televisivo deve avere avuto
un milione di libri, sopra, ed è ancora buono per chissà quanti altri. Chi si sognerebbe
di buttarlo via?
– Lo stesso vale per il mio – disse Margie. Aveva undici anni, lei, e non aveva
visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy. Lui di anni ne aveva tredici.
– Dove l’hai trovato? – gli domandò,
– In casa. – Indicò lui senza guardare, perché era occupatissimo a leggere. – In solaio.
– Di cosa parla?
– Di scuola.
– Di scuola? – Il tono di Margie era sprezzante. – Cosa c’è da scrivere, sulla
scuola? Io la scuola la odio.
Margie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la odiava più che mai. L’insegnante
meccanico le aveva assegnato un test dopo l’altro di geografia, e lei aveva risposto
sempre peggio, finché la madre aveva scosso la testa, avvilita, e aveva mandato a
chiamare l’Ispettore della Contea. Era un omino tondo tondo, l’Ispettore, con una
faccia rossa e uno scatolone di arnesi con fili e con quadranti. Aveva sorriso a Margie
e le aveva offerto una mela, poi aveva smontato l’insegnante in tanti pezzi. Margie
aveva sperato che poi non sapesse più come rimetterli insieme, ma lui lo sapeva e, in
poco più di un’ora, l’insegnante era di nuovo tutto intero, largo, nero e brutto, con un
grosso schermo sul quale erano illustrate tutte le lezioni e venivano scritte tutte le
domande. Ma non era quello il peggio. La cosa che Margie odiava soprattutto era la
fessura dove lei doveva infilare i compiti e i testi compilati. Le toccava scriverli in un
codice perforato che le avevano fatto imparare quando aveva sei anni, e il maestro
meccanico calcolava i voti a una velocità spaventosa.
L’ispettore aveva sorriso una volta finito il lavoro, e aveva accarezzato la testa di
Margie. Alla mamma aveva detto: – Non è colpa della bambina, signora Jones.
Secondo me, il settore geografia era regolato male. Sa, sono inconvenienti che
capitano, a volte. L’ho rallentato. Ora è su un livello medio per alunni di dieci anni.
Anzi, direi che l’andamento generale dei progressi della scolara sia piuttosto
soddisfacente. – E aveva fatto un’altra carezza sulla testa a Margie.
Margie era delusa. Aveva sperato che si portassero via l’insegnante, per ripararlo
in officina. Una volta s’erano tenuti quello di Tommy per circa un mese, perché il
settore storia era andato completamente a pallino.
Così, disse a Tommy: – Ma come gli viene in mente, a uno, di scrivere un libro
sulla scuola?
Tommy la squadrò con aria di superiorità. – Ma non è una scuola come la nostra,
stupida! Questo è un tipo di scuola molto antico, come l’avevano centinaia e
centinaia di anni fa. – Poi aggiunse altezzosamente, pronunciando la parola con cura.
– Secoli fa.
Margie era offesa. – Be’ io non so che specie di scuola avessero, tutto quel tempo
fa. – Per un po’ continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla di lui, poi disse: – In
ogni modo, avevano un maestro?
– Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare. Era un uomo.
– Un uomo? Come faceva un uomo a fare il maestro?
– Be’, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei compiti a casa e
faceva delle domande.
– Un uomo non è abbastanza in gamba.
– Sì che lo è. Mio papà ne sa quanto il mio maestro.
– Ma va’! Un uomo non può saperne quanto un maestro.
– Ne sa quasi quanto il maestro, ci scommetto.
Margie non era preparata a mettere in dubbio quell’affermazione. Disse. – Io non
ce lo vorrei un estraneo in casa mia, a insegnarmi.
Tommy rise a più non posso. – Non sai proprio niente, Margie. Gli insegnanti non
vivevano in casa. Avevano un edificio speciale e tutti i ragazzi andavano là.
– E imparavano tutti la stessa cosa?
– Certo, se avevano la stessa età.
– Ma la mia mamma dice che un insegnante dev’essere regolato perché si adatti
alla mente di uno scolaro o di una scolara, e che ogni bambino deve essere istruito in
modo diverso.
– Sì, però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va, fai a meno di leggere il libro.
– Non ho detto che non mi va, io – sì affrettò a precisare Margie. Certo che voleva
leggere di quelle buffe scuole.
Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones chiamò: – Margie! A
scuola!
Margie guardò in su. – Non ancora, mamma.
– Subito! – disse la signora Jones. – E sarà ora di scuola anche per Tommy, probabilmente.
Margie disse a Tommy: – Posso leggere ancora un po’ il libro con te, dopo la
scuola?
– Vedremo – rispose lui con noncuranza. Si allontanò fischiettando, il vecchio
libro polveroso stretto sotto il braccio.
Margie se ne andò in classe. L’aula era proprio accanto alla sua cameretta, e
l’insegnante meccanico, già in funzione, la stava aspettando. Era in funzione sempre
alla stessa ora, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, perché la mamma diceva
che le bambine imparavano meglio se imparavano a orari regolari. Lo schermo era
illuminato e stava dicendo – Oggi la lezione di aritmetica è sull’addizione delle
frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell’apposita fessura.
Margie obbedì con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c’erano
quando il nonno di suo nonno era bambino. Ci andavano i ragazzi di tutto il vicinato,
ridevano e vociavano nel cortile, sedevano insieme in classe, tornavano a casa
insieme alla fine della giornata. Imparavano le stesse cose, così potevano darsi una
mano a fare i compiti e parlare di quello che avevano da studiare. E i maestri erano
persone…
L’insegnante meccanico stava facendo lampeggiare sullo schermo: – Quando
addizioniamo le frazioni 1/2 + 1/4…
Margie stava pensando ai bambini di quei tempi, e a come dovevano amare la
scuola. Chissà come si divertivano!, pensò.

Isaac Asimov, (1920-1992), è stato uno scrittore, biochimico e divulgatore scientifico statunitense. Fu autore di numerosi romanzi e racconti di fantascienza, polizieschi ed anche autore di letteratura per ragazzi. E’ ritenuto uno dei padri del genere fantascientifico.
Immagine di freepik</a>
Settembre 2024

Il colombre
di Dino Buzzati
Quando Stefano Roí compí i dodici anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. «Quando sarò grande» disse «voglio andar per mare come te. E comanderò delle navi ancora più’ belle e grandi della tua.» «Che Dio ti benedica, figliolo » rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. Era una giornata splendida di sole; e il mare tranquillo. Stefano, che non era mai stato sulla nave, girava felice in coperta, ammirando le complicate manovre delle vele. E chiedeva di questo e di quello ai marinai che, sorridendo, gli davano tutte le spiegazioni. Come fu giunto a poppa, il ragazzo si fermò, incuriosito, a osservare una cosa che spuntava a intermittenza in superficie, a distanza di due-trecento metri, in corrispondenza della scia della nave. Benché il bastimento già volasse, portato da un magnifico vento al giardinetto, quella cosa manteneva sempre la distanza. E, sebbene egli non ne comprendesse la natura, aveva qualcosa di indefinibile, che lo attraeva intensamente. Il padre, non vedendo Stefano più in giro, dopo averlo chiamato a gran voce invano, scese dalla plancia e andò a cercarlo. «Stefano, che cosa fai lì impalato?» gli chiese scorgendolo infine a poppa, in piedi, che fissava le onde. «Papà, vieni qui a vedere.» Il padre venne e guardò anche lui, nella direzione indicata dal ragazzo, ma non riuscì a vedere niente. «C’è una cosa scura che spunta ogni tanto dalla scia» disse «e che ci viene dietro.» «Nonostante i miei quarant’anni» disse il padre «credo di avere ancora una vista buona. Ma non vedo assolutamente niente.» Poiché il figlio insisteva, andò a prendere il cannocchiale e scrutò la superficie del mare, in corrispondenza della scia. Stefano lo vide impallidire. «Cos’è? Perché fai quella faccia?» «Oh, non ti avessi ascoltato» esclamò il capitano. «Io adesso temo per te. Quella cosa che tu vedi spuntare dalle acque e che ci segue non è una cosa. Quello è un colombre. È il pesce che i marinai sopra tutti temono, in ogni mare del mondo. È uno squalo tremendo e misterioso, più astuto dell’uomo. Per motivi che forse nessuno saprà mai, sceglie la sua vittima, e quando l’ha scelta la insegue per anni e anni, per una intera vita, finché è riuscito a divorarla. E lo strano è questo: che nessuno riesce a scorgerlo se non la vittima stessa e le persone del suo stesso sangue.» «Non è una favola?» «No. Io non l’avevo mai visto. Ma dalle descrizioni che ho sentito fare tante volte, l’ho subito riconosciuto. Quel muso da bisonte, quella bocca che continuamente si apre e chiude, quei denti terribili. Stefano, non c’è dubbio, purtroppo, il colombre ha scelto te e finché tu andrai per mare non ti darà pace. Ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti staccherai mai più dalla riva, per nessuna ragione al mondo. Me lo devi promettere. Il mestiere del mare non è per te, figliolo. Devi rassegnarti. Del resto, anche a terra potrai fare fortuna.» Ciò detto, fece immediatamente invertire la rotta, rientrò in porto e, col pretesto di un improvviso malessere, sbarcò il figliolo. Quindi ripartì senza di lui. Profondamente turbato, il ragazzo restò sulla riva finché l’ultimo picco dell’alberatura sprofondò dietro l’orizzonte. Di là dal molo che chiudeva il porto, il mare restò completamente deserto. Ma, aguzzando gli sguardi, Stefano riuscì a scorgere un puntino nero che affiorava a intermittenza dalle acque: il “suo” colombre, che incrociava lentamente su e giù, ostinato ad aspettarlo. Da allora il ragazzo con ogni espediente fu distolto dal desiderio del mare. Il padre lo mandò a studiare in una città dell’interno, lontana centinaia di chilometri. E per qualche tempo, distratto dal nuovo ambiente, Stefano non pensò più al mostro marino. Tuttavia, per le vacanze estive, tornò a casa e per prima cosa, appena ebbe un minuto libero, si affrettò a raggiungere l’estremità del molo, per una specie di controllo, benché in fondo lo ritenesse superfluo. Dopo tanto tempo, il colombre, ammesso anche che tutta la storia narratagli dal padre fosse vera, aveva certo rinunciato all’assedio. Ma Stefano rimase là, attonito, col cuore che gli batteva. A distanza di due-trecento metri dal molo, nell’aperto mare, il sinistro pesce andava su e giù, lentamente, ogni tanto sollevando il muso dall’acqua e volgendolo a terra, quasi con ansia guardasse se Stefano Roi finalmente veniva. Così, l’idea di quella creatura nemica che lo aspettava giorno e notte divenne per Stefano una segreta ossessione. E anche nella lontana città gli capitava di svegliarsi in piena notte con inquietudine. Egli era al sicuro, sì, centinaia di chilometri lo separavano dal colombre. Eppure, egli sapeva che, di là dalle montagne, di là dai boschi, di là dalle pianure, lo squalo era ad aspettarlo. E, si fosse egli trasferito pure nel più remoto continente, ancora il colombre si sarebbe appostato nello specchio di mare più vicino, con l’inesorabile ostinazione che hanno gli strumenti del fato. Stefano, ch’era un ragazzo serio e volonteroso, continuò con profitto gli studi e, appena fu uomo, trovò un impiego dignitoso e rimunerativo in un emporio di quella città. Intanto il padre venne a morire per malattia, il suo magnifico veliero fu dalla vedova venduto e il figlio si trovò ad essere erede di una discreta fortuna. Il lavoro, le amicizie, gli svaghi, i primi amori: Stefano si era ormai fatto la sua vita, ciononostante il pensiero del colombre lo assillava come un funesto e insieme affascinante miraggio; e, passando i giorni, anziché svanire, sembrava farsi più insistente. Grandi sono le soddisfazioni di una vita laboriosa, agiata e tranquilla, ma ancora più grande è l’attrazione dell’abisso. Aveva appena ventidue anni Stefano, quando, salutati gli amici della città e licenziatosi dall’impiego, tornò alla città natale e comunicò alla mamma la ferma intenzione di seguire il mestiere paterno. La donna, a cui Stefano non aveva mai fatto parola del misterioso squalo, accolse con gioia la sua decisione. L’avere il figlio abbandonato il mare per la città le era sempre sembrato, in cuor suo, un tradimento alle tradizioni di famiglia. E Stefano cominciò a navigare, dando prova di qualità marinare, di resistenza alle fatiche, di animo intrepido. Navigava, navigava, e sulla scia del suo bastimento, di giorno e di notte, con la bonaccia e con la tempesta, arrancava il colombre. Egli sapeva che quella era la sua maledizione e la sua condanna, ma proprio per questo, forse, non trovava la forza di staccarsene. E nessuno a bordo scorgeva il mostro, tranne lui. «Non vedete niente da quella parte?» chiedeva di quando in quando ai compagni, indicando la scia. «No, noi non vediamo proprio niente. Perché?» «Non so. Mi pareva… » « Non avrai mica visto per caso un colombre » facevano quelli, ridendo e toccando ferro. «Perché ridete? Perché toccate ferro?» «Perché il colombre è una bestia che non perdona. E se si mettesse a seguire questa nave, vorrebbe dire che uno di noi è perduto.» Ma Stefano non mollava. La ininterrotta minaccia che lo incalzava pareva anzi moltiplicare la sua volontà, la sua passione per il mare, il suo ardimento nelle ore di lotta e di pericolo. Con la piccola sostanza lasciatagli dal padre, come egli si sentì padrone del mestiere, acquistò con un socio un piccolo piroscafo da carico; quindi, ne divenne il solo proprietario e, grazie a una serie di fortunate spedizioni, poté in seguito acquistare un mercantile sul serio, avviandosi a traguardi sempre più ambiziosi. Ma i successi, e i milioni, non servivano a togliergli dall’animo quel continuo assillo, né mai, d’altra parte, egli fu tentato di vendere la nave e di ritirarsi a terra per intraprendere diverse imprese. Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti, metteva piede a terra in qualche porto, subito lo pungeva l’impazienza di ripartire. Sapeva che fuori c’era il colombre ad aspettarlo, e che il colombre era sinonimo di rovina. Niente. Un indomabile impulso lo traeva senza requie, da un oceano all’altro. Finché, all’improvviso, Stefano un giorno si accorse di essere diventato vecchio, vecchissimo; e nessuno intorno a lui sapeva spiegarsi perché, ricco com’era, non lasciasse finalmente la dannata vita del mare. Vecchio, e amaramente infelice, perché l’intera esistenza sua era stata spesa in quella specie di pazzesca fuga attraverso i mari, per sfuggire al nemico. Ma più grande che le gioie di una vita agiata e tranquilla era stata per lui sempre la tentazione dell’abisso. E una sera, mentre la sua magnifica nave era ancorata al largo del porto dove era nato, si sentì prossimo a morire. Allora chiamò il secondo ufficiale, di cui aveva grande fiducia, e gli ingiunse di non opporsi a ciò che egli stava per fare. L’altro, sull’onore, promise. Avuta questa assicurazione, Stefano, al secondo ufficiale che lo ascoltava sgomento, rivelò la storia del colombre, che aveva continuato a inseguirlo per quasi cinquant’anni, inutilmente. «Mi ha scortato da un capo all’altro del mondo» disse «con una fedeltà che neppure il più nobile amico avrebbe potuto dimostrare. Adesso io sto per morire. Anche lui, ormai, sarà terribilmente vecchio e stanco. Non posso tradirlo.» Ciò detto, prese commiato, fece calare in mare un barchino e vi sali, dopo essersi fatto dare un arpione. «Ora gli vado incontro» annunciò. È giusto che non lo deluda. Ma lotterò, con le mie ultime forze.» A stanchi colpi di remi, si allontanò da bordo. Ufficiali e marinai lo videro scomparire laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte. C’era in cielo una falce di luna. Non dovette faticare molto. All’improvviso il muso orribile del colombre emerse di fianco alla barca. «Eccomi a te, finalmente» disse Stefano. «Adesso, a noi due!» E, raccogliendo le superstiti energie, alzò l’arpione per colpire. «Uh» mugolò con voce supplichevole il colombre «che lunga strada per trovarti. Anch’io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare. E tu fuggivi, fuggivi. E non hai mai capito niente.» «Perché?» fece Stefano, punto sul vivo. «Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti, come pensavi. Dal re del mare avevo avuto soltanto l’incarico di consegnarti questo.» E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese fra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa Perla del Mare che dà, a chi la possiede, fortuna, potenza, amore, e pace dell’animo. Ma era ormai troppo tardi. «Ahimè» disse scuotendo tristemente il capo. «Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza: e ho rovinato la tua.» «Addio, pover’uomo» rispose il colombre. E sprofondò nelle acque nere per sempre. Due mesi dopo, spinto dalla risacca, un barchino approdò a una dirupata scogliera. Fu avvistato da alcuni pescatori che, incuriositi, si avvicinarono. Sul barchino, ancora seduto, stava un bianco scheletro: e fra le ossicine delle dita stringeva un piccolo sasso rotondo.
Il colombre è un pesce di grandi dimensioni, spaventoso a vedersi, estremamente raro. A seconda dei mari, e delle genti che ne abitano le rive, viene anche chiamato kolomber, kahloubrha, kalonga, kalu-balu, chalung-gra. I naturalisti stranamente lo ignorano. Qualcuno perfino sostiene che non esiste.

Dino Buzzati (1906 – 1972) è stato uno scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta italiano.
Immagine di freepik</a>
Ottobre 2024

La gola della balena
di Joseph Rudyard Kipling
Una volta c’era nel mare una balena che mangiava i pesci. Mangiava il carpione e lo storione, il nasello e il pesce martello, il branzino e il delfino, i calamaretti e i gamberetti, la triglia e la conchiglia, e la flessuosa anguilla con sua figlia e tutta la sua famiglia con la coda a ronciglio. Tutti i pesci che poteva trovare in tutto il mare, essa li mangiava con la bocca…. così! Tanto che non era rimasto in tutto il mare che un solo pesciolino, un Pesciolino-pieno-d’astuzia che nuotava dietro l’orecchio destro della balena, per tenersi prudentemente fuor di tiro.
Allora la balena si levò ritta sulla coda e disse:
– Ho fame. –
E il Pesciolino-pieno-d’astuzia disse con una vocina parimenti piena d’astuzia:
– Nobile e generoso cetaceo, hai mai mangiato l’uomo? –
– No, – disse la balena. – Com’è?
– Squisito! – disse il pesciolino-pieno-d’astuzia: – squisito ma nodoso.
– Allora portamene un paio, – disse la balena, e con la coda fece spumeggiare il mare.
– Uno per volta basta, – disse il Pesciolino-pieno-d’astuzia. – Se tu nuoti fino al cinquantesimo grado di latitudine nord e quaranta di longitudine ovest, (questo è magia) troverai, seduto su una zattera, in mezzo al mare, con nulla addosso eccetto un paio di calzoni di tela azzurra, un paio di bretelle (non dovete dimenticare le bretelle, cari miei,) e un coltello da tasca, un marinaio naufragato, che – è bene tu ne sii avvertito – è un uomo d’infinite-risorse-e-sagacità.
Così la balena nuotò e nuotò fino al grado cinquantesimo di latitudine nord e quarantesimo di longitudine ovest, più rapidamente che poté, e su una zattera, in mezzo al mare, con nulla indosso eccetto un paio di calzoni di tela azzurra, un paio di bretelle (dovete ricordare specialmente le bretelle, cari miei) e un coltello da tasca, essa vide un unico e solitario marinaio naufragato, coi piedi penzoloni nell’acqua. (Egli aveva avuto da sua madre il permesso di guazzare nell’acqua; altrimenti non l’avrebbe fatto, perché era un uomo d’infinite-risorse-e-sagacità).
Allora la balena aprì la bocca e la spalancò che quasi si toccava la coda, e inghiottì il marinaio naufragato, con tutta la zattera su cui sedeva, col suo paio di calzoni di tela azzurra, le bretelle (che non dovete dimenticare) e il coltello da tasca. Essa inghiottì ogni cosa nella credenza calda e buia dello stomaco, e poi si leccò le labbra…. così, e girò tre volte sulla coda.
Ma il marinaio, che era un uomo di infinite-risorse-e-sagacità, non appena si trovò nel capace e buio stomaco della balena, inciampò e saltò, urtò e calciò, schiamazzò e ballò, urlò e folleggiò, picchiò e morsicò, strisciò e grattò, scivolò e passeggiò, s’inginocchiò e s’alzò, strepitò e sospirò, s’insinuò e gironzò, e danzò balli alla marinara dove non doveva, e la balena si sentì veramente molto infelice. (Avete dimenticato le bretelle?)
Così disse al Pesciolino-pieno-d’astuzia:
– Quest’uomo è molto indigesto, e mi fa venire il singulto. Che cosa debbo fare?
– Digli di uscire, – disse il Pesciolino-pieno-d’astuzia.
Così la balena gridò dal fondo della gola al marinaio naufragato:
– Esci fuori e comportati onestamente. M’hai messo il singulto.
– No! no! – disse il marinaio. – Non così; in maniera molto diversa. Portami alla sponda natìa, ai bianchi scogli di Albione, e ci penserò.
E continuò a ballare più che mai.
– Faresti meglio a portarlo a casa – disse il Pesciolino-pieno-d’astuzia alla balena. – Io ti ho avvertito che è un uomo di infinite-risorse-e-sagacità.
Così la balena si mise a nuotare, a nuotare con le due natatoie e la coda, come meglio le permetteva il singulto; e finalmente vide la sponda nativa del marinaio e i bianchi scogli di Albione, si precipitò sulla spiaggia, spalancò tutta quanta la bocca e disse:
– Per Winchester, Ashuelot, Nasua, Keene e le stazioni della ferrovia di Fitchburg si cambia.
E mentre diceva “Fitch” il marinaio sbucava dalla bocca. Ma mentre la balena era stata occupata a nuotare, il marinaio, che era davvero una persona piena-di-infinite-risorse-e-sagacità, aveva preso un coltello da tasca e tagliata dalla zattera una cancellata a sbarre incrociate, l’aveva saldamente legata con le bretelle (ora sapete perchè non si dovevano dimenticare le bretelle) e poi l’aveva incastrata nella gola della balena, recitando il seguente distico, che, siccome non lo conoscete, qui vi trascrivo:
Con le sbarre della grata
nel mangiar t’ho moderata.
E saltò sulla ghiaia, e si diresse a casa della mamma, che gli aveva dato il permesso di guazzare nell’acqua; e s’ammogliò e d’allora in poi visse felicemente. Com’anche la balena.
Ma da quel giorno ad oggi, la grata in gola che essa non può né espellere, né inghiottire, le impedì di mangiar tutto quello che voleva, eccetto i minuti pesciolini, ed è questa la ragione perchè le balene non mangiano più uomini, bambine e bambini.
Il Pesciolino-pieno-d’astuzia se la svignò e si nascose sotto la soglia dell’Equatore. Temeva che la balena fosse grandemente adirata con lui. Il marinaio portò a casa il coltello da tasca. Aveva indosso soltanto il paio di calzoni di tela azzurra quando s’era messo a camminare sulla ghiaia. Le bretelle l’aveva lasciate strette alla cancellata; e questa è la fine di questo racconto.

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) è stato uno scrittore, poeta e giornalista britannico, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1907, a 41 anni, il più giovane e il primo scrittore di lingua inglese.
Immagine di freepik</a>
Novembre 2024

La figlia di Albione
di Anton Pavlovič Cechov
Alla casa del possidente Griabov si accosta una magnifica carrozza aperta con cerchioni di gomma, grasso cocchiere e sedile di velluto.
Dalla carrozza balzò fuori il capo distrettuale della nobiltà Fiodor Andreic’ Otsòv. In anticamera lo ricevette un domestico assonnato.
– I signori sono in casa? – domanda il capo della nobiltà.
– Nossignore. La padrona e i bambini sono andati in visita, e il padrone e “mamsèl” la governante sono a pescare. Fin da stamane.
Otsòv sosta un poco, rifletté e andò a piedi verso il fiume a cercar Griabov. Lo trova a un paio di verste da casa, vicino al fiume. Avendo guardato giù dall’erta ripa e veduto Griabov, Otsòv scoppia a ridere… Griabov, un uomo grande, grasso, dalla testa grossissima, era seduto sulla sabbia, con le gambe ripiegate sotto di sé alla turca, e pescava alla lenza. Il cappello gli stava sulla nuca, la cravatta gli era scesa da un lato. Accanto a lui stava in piedi un’alta, sottile inglese dagli occhi convessi di gambero e dal gran naso di uccello, simile piuttosto a un uncino che a un naso. Era vestita con un abito bianco di mussolina, attraverso il quale fortemente trasparivano le spalle magre, gialle. Da una cintura dorata le pendeva un orologio d’oro. Ella pure pescava alla lenza. Intorno ai due regnava un silenzio di tomba. Entrambi erano immobili, come il fiume su cui nuotavano i loro galleggianti.
– Una voglia da morire, ma un destino crudele! – si mise a ridere Otsòv. – Buon giorno, Ivàn Kuzmic!
– Ah… sei tu?-domanda Griabov, senza staccar gli occhi dall’acqua. – Sei arrivato?
– Come vedi… E tu ti occupi ancor sempre della tua sciocchezzuola!
Non te ne sei ancora disavvezzato?
– Che diavolo… E’ tutto il giorno che pesco, dal mattino… Non so perché, oggi si pesca male. Non abbiamo preso nulla né io, né questa fantasima. Stiamo qui, stiamo qui, e almeno si pigliasse un accidente!
C’è addirittura da gridare al soccorso.
– E tu sputaci su. Andiamo a ber la vodka!
– Aspetta… Forse qualcosa acchiapperemo. Verso sera il pesce abbocca meglio.. Son qui, fratello, fin da stamane! Una noia così grossa che nemmeno te lo posso esprimere. M’ha proprio trascinato il diavolo a prender quest’abitudine della pesca! So ch’è un’insulsaggine, e sto qui! Sto qui come un lazzarone qualunque, come un forzato, e guardo l’acqua, come un qualunque imbecille! Alla falciatura bisogna andare, e io pesco. Ieri a Chapanievo officiava Sua Eminenza, e io non ci andai, rimasi qui con questa specie di storione… con questa diavolessa…
– Ma… sei impazzito? -domanda Otsòv, sbirciando impacciato l’inglese. – Sparli davanti a una signora… e di lei stessa…
– Ma che il diavolo la porti! Tant’è, di russo non capisce un’acca.
Parlane bene, parlane male, per lei è tutt’uno! Guarda il suo naso!
Soltanto il naso ti farà svenire! Stiamo insieme giornate intere, e almeno dicesse una parola! Sta lì come uno spauracchio e sgrana le sue lanterne sull’acqua.
L’inglese sbadiglia, cambia il vermicciolo e getta l’amo.
– Mi meraviglio, fratello, non poco! – continua Griabov. – Vive questa scema in Russia da dieci anni, e almeno sapesse una parola di russo!… Un nostro qualunque aristocraticuccio va nel loro paese e ben presto impara a bestemmiarne la lingua, loro invece… il diavolo li conosce! Tu guardale il naso! Il naso guardale!
– Su via, smettila.., Non sta bene… Perché dai addosso a una donna?
– Lei non è donna, ma ragazza… Sogna, scommetto, i fidanzati, questa pupattola del diavolo. E manda non so che odor di putredine… L’ho presa in odio, fratello! Non posso vederla con indifferenza! Quando mi guarda coi suoi occhiacci, mi sento tutto rimescolato, come se avessi dato del gomito contro una ringhiera. Le piace anche pescare.
Guardala: pesca, e celebra un rito! Guarda ogni cosa con disprezzo…
Sta lì, la canaglia, e ha coscienza di esser uomo e, per conseguenza, «re della natura». E sai come si chiama? Uilka Ciàrlsovna Tfais!
Poh!… non si può nemmeno pronunciare!
L’inglese, avendo udito il suo nome, gira lentamente il naso dalla parte di Griabov e lo misura con uno sguardo sprezzante. Da Griabov leva gli occhi su Otsòv e lo inonda di disprezzo. E tutto ciò in silenzio, con gravità e lentamente.
– Hai visto? – domanda Griabov, ridendo forte. – To’, dice, è per voi! Ah, tu, fantasima! Solo per i bambini tengo questo tritone. Se non ci fossero i bambini, anche a dieci verste dalla mia proprietà non la lascerei avvicinare… Il suo naso è come quello dell’avvoltoio…
E la vita? Questa pupattola mi rammenta un lungo chiodo. E così, sai, la prenderei e la pianterei in terra. Aspetta… Da me, pare, abbocca…
Griabov balza in piedi e solleva la canna. La lenza si tese… Griabov tira ancora una volta e non poté trar fuori l’amo.
– S’è impigliato! – disse e fece una smorfia. – A una pietra, probabilmente… Che il diavolo lo porti…
Sul viso di Griabov si dipinse la sofferenza. Sospirando, movendosi inquieto e borbottando maledizioni, egli comincia a tirar la lenza. Il tirare non valse a nulla. Griabov impallidì.
– Che seccatura! Bisogna scendere in acqua.
– E tu smetti!
– Non si può… Verso sera si pesca bene… Guarda un po’ che scocciatura, che il Signore mi perdoni! Toccherà scendere in acqua.
Toccherà! E se tu sapessi quanta poca voglia ho di spogliarmi! Bisogna cacciar via l’inglese… In sua presenza è scomodo spogliarsi. E’ pur sempre, vedi, una dama!
Griabov si tolse cappello e cravatta.
– “Miss”… eh-eh-eh… – si rivolse all’inglese. – Miss Tfais!
“Ze vu pri” … Be’, come dirle? Be’, come dirti, perché tu capisca? Ascoltate… là! Andate là – Senti?
“Miss” Tfais inondò Griabov di disprezzo ed emise un suono nasale.
– Che cosa? Non capite? Vattene di qui, ti si dice! Devo spogliarmi, pupattola del diavolo! Vattene là! Là!
Griabov tira la miss per una manica, le indica i cespugli e si accoccolò: va’ dietro i cespugli, le diceva con ciò, e nasconditi là.
L’inglese, movendo con energia i sopraccigli, pronuncia rapidamente una lunga frase in inglese. I due possidenti scoppiarono a ridere.
– E’ la prima volta in vita mia che sento la sua voce… Non c’e che dire, una vocina! Non capisce! Su via, che ho da fare con lei?
– Sputaci su! Andiamo a ber la vodka!
– Non si può, adesso si deve pescare…, La sera… Be’, che vuoi che faccia! Che scocciatura! Toccherà spogliarsi in sua presenza…
Griabov si tolse giacca e panciotto e sedette sulla sabbia per cavarsi gli stivali.
– Ascolta, Ivàn Kuzmic’, – disse il capo della nobiltà, ridendo forte nella mano. – Questo poi, amico mio, è scherno, derisione.
– Nessuno la prega di non capire! Sarà di lezione per loro, stranieri!
Griabov si leva gli stivali, i calzoni, si tolse la biancheria e si ritrova vestito come Adamo. Otsòv si prese il ventre. Egli era arrossito dalle risa e dalla confusione. L’inglese moveva i sopraccigli e batteva gli occhi… Sulla sua faccia gialla correva un altezzoso, sprezzante sorriso.
– Bisogna freddarsi un poco, -disse Griabov, battendosi sulle anche. – Dimmi di grazia, Fiodor Andreic’, perché a me ogni estate viene uno sfogo sul petto?
– Ma scendi al più presto in acqua o copriti con qualche cosa!
Animale!
– E almeno si fosse confusa, la vigliacca! – disse Griabov, entrando in acqua e segnandosi. – Brr… che acqua fredda… Guarda come muove i sopraccigli! Non se ne va… Sta al disopra della folla! He- he-he!… Nemmeno in conto di uomini ci tiene!
Entrato fino ai ginocchi nell’acqua e drizzatosi in tutta la sua enorme statura, egli strizza l’occhio e disse:
– Questa, fratello, per lei non è l’Inghilterra!
“Miss” Tfais cambia freddamente il vermicciolo, sbadigliò e gettò l’amo. Otsòv si volse in là. Griabov sganciò l’uncino, si tuffò e, soffiando, uscì dall’acqua. Di lì a due minuti era già seduto sulla sabbia e tornava a pescare.

Anton Pavlovič Čechov (1860-1904) è stato uno scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo.
Immagine di freepik</a>
Dicembre 2024

Il disco
di Jorge Luis Borges
Sono un taglialegna. Il nome non importa. La capanna in cui sono nato e dove presto dovrò morire è sul limitare del bosco. Il bosco, dicono, si stende fino al mare che circonda tutta la terra e su cui viaggiano case di legno uguali alla mia. Non so; non l’ho mai visto. Non ho mai visto neppure l’altro lato del bosco. Quando eravamo ragazzi, mio fratello maggiore mi fece giurare che assieme avremmo tagliato tutto il bosco finché non fosse rimasto un solo albero. Mio fratello è morto, e ora cerco, e continuerò a cercare, un’altra cosa. Verso ponente scorre un fiumiciattolo nel quale so pescare con le mani. Nel bosco ci sono i lupi, ma i lupi non mi spaventano e la mia ascia non mi ha mai tradito. Non ho tenuto il conto dei miei anni. So che sono molti. I miei occhi non vedono più. Nel villaggio, dove ormai non vado perché mi perderei, ho fama di avaro, ma cosa può aver messo via un taglialegna del bosco? Chiudo la porta di casa con un sasso perché non entri la neve. Un pomeriggio sentii dei passi stanchi e poi un colpo. Aprii ed entrò uno sconosciuto. Era un vecchio alto, avvolto in una coperta logora. Una cicatrice gli solcava il viso. Gli anni sembravano avergli dato autorità più che debilitarlo, ma notai che faceva fatica a camminare senza l’appoggio del bastone. Scambiammo qualche parola che non ricordo. Alla fine disse: «Non ho casa e dormo dove posso. Ho attraversato tutta la Sassonia». Quelle parole si addicevano alla sua vecchiaia. Mio padre parlava sempre della Sassonia; ora la gente dice Inghilterra. Avevo un po’ di pane e di pesce. Non parlammo mentre mangiavamo. Iniziò a piovere. Con alcune pelli gli preparai un giaciglio sul pavimento di terra battuta, dove era morto mio fratello. Al cader della notte ci addormentammo. Albeggiava quando uscimmo di casa. Non pioveva più e la terra era coperta di neve fresca. Gli cadde il bastone e mi ordinò di raccoglierlo. «Perché dovrei obbedirti?» gli dissi. «Perché sono un re» rispose. Pensai che fosse pazzo. Presi il bastone e glielo detti. Parlò con una voce diversa. «Sono il re dei Secgens. Nella dura battaglia li ho portati tante volte alla vittoria, ma nell’ora fatale ho perso il mio regno. Il mio nome è Isern e sono della stirpe di Odino». «Io non venero Odino» gli risposi. «Io venero Cristo». Proseguì come se non mi avesse sentito: «Vago sulle strade dell’esilio, ma sono ancora il re, perché ho il disco. Vuoi vederlo?». Aprì la mano ossuta. Non c’era niente. Era vuota. Solo allora mi resi conto che l’aveva sempre tenuta chiusa. Disse guardandomi fisso: «Puoi toccarlo». Con una certa diffidenza, sfiorai con la punta delle dita il suo palmo. Sentii qualcosa di freddo e vidi un brillio. La mano si chiuse bruscamente. Non dissi nulla. L’altro proseguì con pazienza come parlasse a un bambino: «E il disco di Odino. Ha un solo lato. Sulla terra non c’è nient’altro che abbia un solo lato. Finché l’ho in mano, sarò il re». «E d’oro?» gli chiesi. «Non lo so. E il disco di Odino e ha un solo lato». Allora fui preso dalla bramosia di possedere il disco. Se fosse stato mio, avrei potuto venderlo per una barra d’oro e sarei diventato re. Dissi al vagabondo che ancora oggi odio: «Ho un cofano pieno di monete nascosto nella capanna. Sono d’oro e splendono come la mia ascia. Se tu mi dai il disco di Odino, io ti do il cofano». Ma lui rispose testardo: «Non voglio». «Allora» gli dissi «puoi riprendere il tuo cammino». Mi voltò le spalle. Un colpo d’ascia alla nuca fu più che sufficiente per farlo vacillare e cadere, ma mentre cadeva aprì la mano e vidi il brillio nell’aria. Segnai bene il posto con l’ascia e trascinai il morto fino al ruscello, che era in piena. Ce lo gettai dentro. Tornando a casa, cercai il disco. Non lo trovai. Sono anni che continuo a cercarlo.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, noto semplicemente come Jorge Luis Borges (1889-1986), è stato uno scrittore, poeta, saggista e traduttore argentino.
Immagine di freepik</a>